RICERCHE SUBACQUEE NEI FONDALI DEL MARE DI GELA
Redazione
di SikeliaNews dell’11
Febbraio 2017:
“Il mare di Gela continua a restituire preziosi
beni archeologici, storici e culturali, dopo
averli custoditi per 2.700 anni. Di fronte al
litorale di contrada Bulala, a est della città,
i sommozzatori del reparto operativo aeronavale
della Guardia di finanza di Palermo, in
collaborazione con la Sovrintendenza al mare,
hanno proceduto al recupero di due elmi corinzi,
un'ampolla massaliota (cioè dell'antica colonia
greca di Marsiglia, in Francia), un'anfora
arcaica e 47 lingotti di oricalco, il
leggendario "metallo di Atlantide" costituito da
una preziosa lega di rame e zinco. Altri 39
lingotti erano stati recuperati nel dicembre
2014, frutto di una scoperta unica nel suo
genere per l'intero Mediterraneo.”

L’enorme consistenza di reperti archeologici
presenti nei fondali del mare di Gela, a cui ha
dato un notevole contributo il sub locale Franco
Cassarino nel loro recupero, comporta un
interessamento primario da parte delle
istituzioni competenti, cosa che purtroppo non
avviene, soprattutto per mancanza di
finanziamenti regionali, ma anche perché non c’è
interesse della politica a tutti i livelli a
partire da quello locale. Ancora, purtroppo, non
si riesce a comprendere l’importanza che può
avere lo sfruttamento di questi “giacimenti
culturali” per il turismo e soprattutto come
volano per l’economia e l’occupazione giovanile
della città di Gela e del suo circondario.
Non è concepibile poi che la Regione rimanga
ancora sorda alla tematica del bene culturale,
di Gela in particolare; non si vuole capire che
potenziando l’attività archeologica di Gela ne
trarrebbero frutto la stessa città e la Sicilia
intera.
Comunque sia, con la presente si vuole dare un
contributo ribadendo un’ulteriore valorizzazione
non solo dei beni culturali terrestri, lo si fa
dal 1981, ma anche di quelli sommersi, il tutto
avvalendosi di strutture specialistiche e di
professionalità. C'è bisogno di un anello di
congiunzione del Comune di Gela con la
Soprintendenza del Mare, quella di Caltanissetta
e del Museo, per mettere in atto le attività
connesse all'archeologia subacquea.
L’azione dell’idea
dello
scrivente, si prefigge anche lo scopo della
ricerca e del recupero dei reperti bellici dello
sbarco americano a Gela del 1943; questa è
un’altra miniera di reperti di archeologia
militare ancora quasi del tutto inesplorata che
si riferisce a diverse tipologie d’imbarcazioni
affondate, materiale bellico vario,
equipaggiamenti e a diverse decine di aerei
americani Dakota C-47 abbattuti per fuoco amico,
che giacciono ancora sommersi e che, se
recuperati, darebbero una svolta alla
realizzazione del tanto agognato museo dello
sbarco a Gela.
Nell'area di Abuqir ,"ramo Canopico" del Nilo,
si trovava la città di Canopo (Thonis), che fu
il più importante centro commerciale egiziano
sul Mediterraneo prima della creazione di
Alessandria. In un periodo compreso fra il IV e
il II secolo a.C., l'acqua e la sabbia avevano
già inghiottito questo antico porto faraonico
del quale s'era persa l'ubicazione. Ma più tardi
ad Erakleion greca toccò la stessa inesorabile
sorte della più antica Thonis, ed attualmente si
trova anch'essa sommersa ad una profondità di
una decina metri nel mare della baia di Abuqir.
Nel 2000 con l’ausilio di moderne tecnologie,
incluse le onde magnetiche, è stata mappata
l’intera area sommersa, “Abbiamo una città
faraonica antica di 2500 anni, congelata nel
tempo” ha detto Franck Goddio, l’archeologo
francese che ha guidato un team internazionale
nella ricerca.
Ci chiediamo perché non si fa la stessa cosa per
i fondali di Gela? Non si può richiamare in vita
il compianto Prof. Sebastiano Tusa che già aveva
creato le condizioni per una mappatura del
fondale di Bulala nel mare di Gela. Anzi chi di
dovere perché non riprende quanto fatto prima
dal suo predecessore.
TRE
MUSEI DIFFUSI NELLA CITTA’ DI GELA? LA RISPOSTA
E’ SI’!!
QUELLI
DI ARCHEOLOGIA GRECA, ARCHEOLOGIA MILITARE
E
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Qualche decennio fa
chi scrive ebbe la “sfacciataggine” di proporre
a varie istituzioni, come la Soprintendenza e
l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali
(ovviamente anche per conoscenza al Comune di
Gela, in modo da essere interessato alla
proposta), di realizzare a Gela un Museo Diffuso
dal momento che erano in corso diversi scavi in
varie parti della città, scavi che il più delle
volte mettevano in luce diversi siti
archeologici con il ritrovamento di reperti che
sistematicamente venivano trasferiti al locale
Museo archeologico, senza nemmeno che lo stesso
sito in modo postumo venisse segnalato da un
qualsiasi cartello; ovviamente non esisteva
allora questa aspettativa perché lo scavo faceva
parte del lavoro di un “capo” archeologo e come
tale doveva servire allo stesso per
pubblicazioni, titoli, e quant’altro si sarebbe
potuto ricavare e quindi non a servizio della
comunità gelese. Figuriamoci!!
Anche in tempi
recenti fu ripetuta dallo scrivente la proposta
del Museo Diffuso, in particolare quando fu
realizzato uno scavo in via Genova a Capo
Soprano dove furono trovate due siti di
necropoli del V e del IV sec. a.C., ma niente da
fare. E così in via Cicerone e in altre zone più
o meno vicine scavate successe la stessa
situazione di indolenza e, perché no,
strafottenza nel recepire l’dea del Museo
Diffuso, idea importante perché prevedeva un
itinerario per le vie della città su diversi
siti dal punto di vista di un possibile rilancio
del turismo archeologico.
Andiamo adesso in
via Di Bartolo, una strada del Borgo, in una
vasta zona a nord del Vallone Pasqualello dove
in antico, a partire da Via Matteotti per
arrivare fino al cimitero e oltre, esistevano
(ed esistono ancora sotto le strade e le case)
necropoli a partire dal VII fino ad arrivare al
IV sec. a.C. Proprio
in via Di Bartolo Paolo Orsi, nei primi anni del
1900, scavando, scoprì qualcosa come 37
sepolture con una serie numerosa di reperti
archeologici che assieme a moltissimi altri (un
calcolo documentato dello scrivente ne arriva a
contare fino a 7.000 reperti integri), furono
trasferiti al Museo di Siracusa e mai più
restituiti anche perché, nè prima né dopo, non
fu mai richiesta la debita restituzione degli
stessi reperti.
Quindi, nella zona
del Borgo scavò, a partire da aprile-giugno del
1900 e fino al 1905, per ben 6 anni, Paolo Orsi
per poi andare fino all’attuale Cimitero
Monumentale. “…senza menar vanto dell’opera mia,
frutto di un dovere devotamente ed amorosamente
compiuto, ho ben la coscienza d’avere rivelato
agli studiosi uno dei focolari più ricchi e men
noti della Sicilia antica, sul quale la
letteratura archeologica era fin qui
completamente negativa.” Lo stesso Orsi
affermava che “…io penso, che tenuto conto delle
falde di terreno adiacenti, né da me esplorate,
il numero totale dei sepolcri del Borgo si possa
calcolare in 2.000 circa…”.
Comunque con questo
scritto, si vuole ulteriormente rendere
manifesta la proposta di ritornare a scavare
nelle vie del Borgo e oltre per realizzare su
ogni ritrovamento la stessa situazione prodotta
ultimamente in via Di Bartolo e ciò varrebbe per
le seguenti vie, sempre del Borgo; Via Bonanno,
via Buscemi, via Salerno, via Sammito (già via
Cubba), via Martorana, via F.lli Bandiera. Ma
non solo, anche per diversi ex predii (come il
predio Lauricella, a est del Cimitero
monumentale), il predio della necropoli La
Paglia (a sud della Villa comunale), ed ancora
quelli di Rosso-Russo, Catalano e Tascone,
Romano e Lo Bartolo, Jozza, Bentivegna, ecc.
In merito alla
denominazione della via Di Bartolo, non si
riesce a sapere nulla di essa, però, sulla base
di altre vie del Borgo data a nominativi di
militari deceduti eroicamente nella Prima Guerra
Mondiale, è probabile che si tratti di un
militare nostrano deceduto appunto in quella
Guerra.
Per il secondo
museo diffuso si coglie l’occasione per
contestualizzare un “Bunker Tour” da proporre
come itinerario turistico di Archeologia
Militare. Ma tutto ciò, purtroppo, è sconosciuto
a chi si dovrebbe interessare dell’aspetto
turistico della città, anche se ultimamente una
commissione consiliare si è interessata a questa
tematica dell’Archeologia Militare e di cui, in
mancanza di una risposta, ci si chiede come sia
andata a finire!!
L’itinerario
turistico di Archeologia Militare (quello di
Gela è il più consistente della Sicilia) si
potrebbe snodare sicuramente nel nostro
territorio dal momento che tra il 1941 e iI
1943, furono costruiti più di 200 fortinì di
diverso tipo che col passare degli anni si sono
ridotti a meno della metà; il loro numero fino
al 1987 era di 186 unità. Un sistema difensivo
costiero di Gela e d'intorni, che alla luce
delle opere rimaste, è riferibile essenzialmente
a quattro tipologie:
1)
Postazioni pluriarma delle casematte nella zona
Capo Soprano, a nord dell’ex ciminiera del
Liquirificio Marletta-Cellura;
2)
Postazioni circolari monoarma di capisaldi con
due tipologie, riscontrabili a Feudo Nobile,
Monte Zai e Apa sulla SP8 per Butera; Ponte
Olivo e CasteIIuccio; c.da Grotticel!e; Stazione
di Butera, Monte Falcone e Diga Comunelli; c.da
Poggio Tenna, a est delI'ex Aeroporto di Ponte
Olivo; c.da Priolo. Ed ancora diversi bunker
isolati: sulla SS.115 per Vittoria e Licata, SP8
per Butera, centro storico di Gela (Acropoli,
Carrubbazza, Mura Timoleontee, Punta Vigne,
Porto rifugio)
3)
Postazioni circolari cilindriche infossate:
Feudo Nobile e Castelluccio;
4)
Rifugi antischegge in c.da Dell’Oliva sulla
strada per Mazzarino.
Ci sarebbe un terzo
museo diffuso da realizzare, quello di
Archeologia Industriale, relativo ad alcuni
impianti petroliferi da tempo dismessi, ma
l’ENI, a cui si è rivolto lo scrivente per la
proposta, al di là di una cortese risposta
sembra …aver dimenticato!! E la Politica locale?
RESTITUIRE AL SANTUARIO
IL QUADRO BIZANTINO
DI MARIA SS. D’ALEMANNA, PATRONA DI GELA

Per quanto lo scrivente si sia interessato della
storia del Santuario di Gela, molte persone si
sono poste spesso delle domande e chiesto dei
chiarimenti sul culto religioso in questo
edificio, ritenuto particolarmente sacro dalla
popolazione gelese in quanto legato alla sua
Patrona Maria Ss. d’Alemanna. E, pertanto, sulla
base di diverse documentazioni, si è arrivati
alla conclusione (che è stata anche di altri
studiosi, antichi e moderni) che a Gela, a
partire dal 1200 (ma anche precedentemente in
epoca greca), sia esistito e tuttora esiste un
santuario, quello di Maria Ss. d’Alemanna al
Villaggio Aldisio, uno e uno solo fino ad oggi a
partire da quella lontana epoca trecentesca.
Addirittura rispetto ad altri santuari del tardo
medioevo il nostro, ha anche la prerogativa di
mantenere ancora intatto il punto (trasformato
in una botola) in cui nel 1476 fu trovata
l’icona della Madonna da un contadino che arava
la terra, fortunatamente sepolta lì per evitare
di essere distrutta dagli iconoclasti,
movimento contro l'uso e
il culto delle sacre immagini che fu provocato
dall'imperatore bizantino Leone III Isaurico.
E anche se nel dopoguerra il quadro della
Patrona è stato trasferito definitivamente in
chiesa Madre, trasferimento a dire dello
scrivente in modo illecito e peraltro si
oserebbe dire …blasfemo, i fedeli sanno che “la
Madonna è rimasta” nel posto dove fu ritrovata
la sua immagine dipinta. Addirittura dopo tutta
una serie di recenti vicissitudini, spesso
create volutamente chissà per quali reconditi
motivi a danno del Santuario, durate più di
mezzo secolo, lo stesso edificio dopo tante
lotte del comitato, appositamente creato, è
stato riaperto al culto nel 1985; tra l’altro
una cosa importante è che da allora si sta
riprendendo l’uso, per un’antichissima
tradizione, di prelevare dalla citata botola un
po’ di terriccio (come se fosse stato a contato
con l’icona della Madonna) e metterlo in un
sacchetto per portarselo a casa per una
spiritualità sacra di protezione in ogni
necessità.
L’illecita detenzione e la non restituzione del
quadro della Madonna d’Alemanna continuano
purtroppo fino ad oggi con il silenzio indolente
di chi dovrebbe decidere per la giusta
riconsegna, non fosse altro per avere il dovuto
rispetto religioso di un’antica tradizione che
vedeva il quadro della Vergine in pianta stabile
al Santuario; e da lì, come ci riferisce lo
storico terranovese Salvatore Damaggio Navarra
nella sua pubblicazione “Maria d’Alemanna in
Terranova” del 1915, trasportata dai contadini
nella “macchinetta” (ovvero la raggiera, un
antico supporto di legno dorato), era trasferita
in città in corteo solenne tre volte l’anno,
presenti il Governatore e i Magistrati in
eleganti carrozze, seguita da tutto il popolo e
in particolare da molte donne a piedi nudi che
avevano espresso un voto alla Madonna; in
particolare, in gennaio alla chiesa del Carmine,
in occasione dell’annuale ricorrenza dello
scampato pericolo dal terremoto dell’11 gennaio
del 1693; allora, come riportano le cronache
storiche, le scosse telluriche furono così
violente che distrussero molte città dell’Isola
specialmente nella sua parte orientale.
Terranova e i suoi abitanti non ebbero nessun
danno e ciò, tradizione popolare vuole, grazie
alla protezione della Vergine a cui la
popolazione terranovese in uno slancio corale di
fede si rivolse in preghiera. Ancora il popolo
ricorda i famosi versi coniati in quella
tremenda occasione:
“ALL’UNNICI ‘I JNNARU A VINTUN’URA
SI VITTI E NUN SI VITTI TERRANOVA;
SE UNN’ERA PPI’ MARIA, NOSTRA SIGNURA,
PETRI SU’ PETRI FURRA TERRANOVA”
Ma non fu
solo il Pitrè nel 1888 a scrivere del culto
della Madonna d’Alemanna, anche prima e dopo
dello stesso esistono dei riferimenti di antichi
scrittori come
Rocco Pirri nel 1644, di Antonio Mongitore nel
1721, di Vito Amico nel 1760, di Gioacchino Di
Marzo nel 1855, di Salvatore Damaggio Navarra
nel 1915, del reverendo Luigi Aliotta nel 1954 e
qualche anno fa anche dallo scrivente.
Le altre due volte l’icona bizantina della
Madonna era trasferita in chiesa Madre
rispettivamente nel mese di maggio (la
tradizione mariana legata a questo mese, risale
al XIII secolo ad opera del re spagnolo Alfonso
X il Saggio, re di Castiglia e di León), con una
solenne esposizione, e nell’ultima domenica di
agosto per dar corso ai festeggiamenti patronali
del successivo otto di settembre che sono stati
sempre grandiosi e religiosamente sentiti, anche
se da diversi anni sono state propinate alla
popolazione gelese diverse situazioni farlocche
e inventate, come ad esempio il ”Palio
dell’Alemanna”, che sotto certi aspetti assieme
ad armigeri, sbandieratori, arcieri e
quant’altro non appartenenti alla nostra
tradizione della festa si
è
dimostrato una
carnevalata.
In realtà fino alla fine degli anni Cinquanta il
“Palio della Madonna”, quello vero, consisteva
in una gara di due cavalli con fantini, e
qualche volta anche senza, tutti addobbati con
divisa a colori sgargianti che partivano allo
sparo di un grosso petardo (un “corpu
di mascuni”) da Molino a Vento a est del
centro murato. Il percorso si snodava lungo
tutta l’arteria principale del Corso fino al
Camposanto, da lì, dopo l’esplosione di un altro
petardo, si invertiva la corsa per rifare lo
stesso percorso fino al traguardo che era posto
nei pressi della “chiazziteddra”
(piazzetta), all’incrocio tra il Corso e via
Porta Marina (oggi via Marconi). Durante la gara
i marciapiedi del Corso, dalla “chiazziteddra”
ai “Quattro
Canti” (oggi piazza Martiri della Libertà)
erano transennati con travi legno. Di queste
corse oggi, che lo scrivente sappia, non esiste
nessuna fotografia, ma per chi non ha mai
assistito può farsene un’idea osservando una
foto di un acquerello di Salvatore Solito qui
riportata.
I cavalli utilizzati per le corse provenivano in
genere dal Marocco ovvero dalla
Barberia,
un’antica denominazione di diverse regioni del
Nord-Africa, e per tale provenienza erano
chiamati “bàrberi”.
Ma oltre a questo tipo di cavalli ne esisteva un
altro, utilizzato anche per le gare durante i
giorni della festa; erano i cosiddetti “Giannetti”
o “Ginnetti”,
cavalli da corsa di razza spagnola piccoli e
snelli.
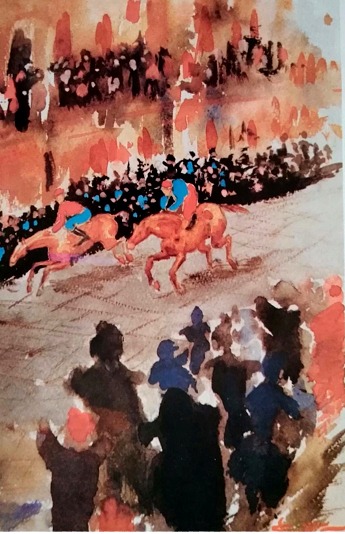
Ritornando al quadro della Madonna, dopo il suo
trasferimento temporaneo nelle suddette tre
date, l’icona rientrava nel Santuario e così da
ben quasi 500 anni, fino al 1945. In
particolare, nel capitolo LVI dell’opera di
Giuseppe Pitrè del 1888 sulle tradizioni
popolari in Sicilia, dal titolo “La festa di S.
Maria d’Alemanna in Terranova Sicula” a cura di
Aurelio Rigoli, si legge: “…s’innalza solitaria,
tra vasti e ubertosi campi d’intorno,
un’elegante chiesuola, sacra alla B.V. Maria
d’Alemanna, detta comunemente Manna. Si venera
quivi, da remotissimo tempo, una pregevole
immagine dell’Augusta Madre di Dio del medesimo
titolo, alla quale, siccome Patrona della Città,
si celebra ogni anno la festa il dì 8 settembre
con rito solenne…”. Ed ancora “…Questa Madonna,
già intesa “saccareddra”, cioè acquaiola, perchè
apportatrice di piogge, viene condotta in città
tre volte l’anno: in Gennaio alla chiesa del
Carmine per la festa del Crocifisso, e nella
parrocchia in Maggio e in Settembre, festa della
Natività di Maria…”.
Nel mese di maggio anticamente la festa durava
l’intero mese, ed i devoti a piedi scalzi si
recavano al santuario recitando il rosario e, ad
ogni gloriapatri, la giaculatoria:
“Beddra
‘n terra, beddra ‘n celu,
Beddra siti ‘n paradisu;
Beddru assai è lu vostri visu.
Pri ssu figghiu vostru ‘n brazza,
Conciditimi ‘na grazzia!
Cunciditimilla a mia,
Chi vi dicu ‘a vimmaria”.