STRADA
STATALE 115

La strada
statale 115 Sud Occidentale Sicula è una strada
statale italiana che collega le città di Trapani
e Siracusa passando per Agrigento, Gela e
Modica. La strada attraversa cinque province
della costa mediterranea della Sicilia: quelle
di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e
Siracusa; inoltre è parte integrante degli
itinerari europei E931, cioè una strada europea
il cui tragitto si trova completamente in
territorio italiano con il suo percorso che
corrisponde per un tratto alla Strada statale
115 Sud Occidentale Sicula, precisamente
quella che
collega
Mazara del Vallo
con
Gela
e che attraversa i centri principali di
Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Porto
Empedocle, Agrigento, Palma di Montechiaro e
Licata. Questa strada fa parte anche della E45,
una delle più lunghe strade europee che collega
la cittadina norvegese di Karesuando a Gela con
l’attraversamento di sette nazioni quali, oltre
la stessa Norvegia, Finlandia, Svezia,
Danimarca, Germania, Austria e Italia. E in
Italia tale E45 rappresenta un'importante
arteria che collega il Nord con il Sud d’Europa,
passando per la dorsale appenninica.
La strada statale
115, di circa 383 chilometri, è quindi la più
lunga dell'isola e si divide in due tronchi, da
Trapani a Porto Empedocle e da Agrigento a
Siracusa. La strada statale 115 venne istituita
nel 1928 con il seguente percorso: Trapani -
Marsala - Mazara - Castelvetrano - innesto con
la n. 118 presso Agrigento - Terranova (Gela) -
Modica - Spaccaforno - Siracusa.
La SS 115 nella
zona di Gela e ancor prima della sua istituzione
ha rappresentato il sistema viario che ha
consentito a migliaia di contadini di
raggiungere i campi agricoli delle maggiori
contrade del territorio. A partire dagli anni
Sessanta sulla stessa statale, in particolare
quella verso Licata, c’è stato un notevole
incremento del traffico veicolare dovuto al
raggiungimento delle zone balneari e
residenziali estive.
Nel 2006 l’ANAS
con l’innesto sulla SS 115 ha completato il
percorso della SS 626 Gela-Caltanissetta.
Dagli anni
Sessanta in poi, parte della SS115, quella
passante a nord della città, ha preso la
denominazione di Via Venezia; tale
denominazione, a quanto è dato sapere, è stata
scelta dalla commissione di toponomastica perché
nei periodo di pioggia intensa sistematicamente
si allaga. E c’è da crederci anche perché,
sempre tale istituzione, tempo fa denominò le
vie della frazione di Manfria con i toponimi di
piante utilizzando …un manuale di botanica.
A proposito della
SS115 un’ultima notizia, quella che esiste
ancora a Gela un pietra miliare all’angolo del
marciapiede ad ovest del Convitto Pignatelli con
la scritta “A.A.S.S. STRADA STATALE 115” (ovvero
Azienda Autonoma Statale Strade), istituita nel
1928 quando ancora le strade statali passavano
all’interno delle città.
%20STRADA%20STATALE%20N.%20115%20(1).jpg)
LA RIVOLTA CONTRO I BORBONI
RAFFORZO’ L’ARISTOCRAZIA

Giuseppe Navarra
Nel 1898 nella città di Palermo si svolsero i festeggiamenti per la ricorrenza del 50° anniversario dei Moti Siciliani, avvenuti nel gennaio 1848 contro l'oppressore borbonico. In quel mese proprio a Palermo era scoppiato il primo tra i tanti moti del Quarantotto, primo non solo fra i moti italiani, ma anche fra quelli europei. Fu proprio Palermo che, dopo il fallimento dell'insurrezione messinese del 1° settembre del 1847, assunse funzione guida nella Sicilia contro la dominazione borbonica.
Il movimento insurrezionale, diretto agli inizi da Giuseppe La Masa e Rosolino Pilo, ed in seguito da un comitato generale presieduto da Ruggero Settimo, sconfisse il 24 gennaio le truppe napoletane di Ferdinando II, re del Regno delle Due Sicilie, le quali dopo quattro giorni di resistenza furono costrette ad evacuare la città.
Anche a Gela, il 28 gennaio dello stesso anno, una guarnigione militare borbonica veniva sgominata dalla folla capitanata dal Cav. Giacomo Navarra Navarra, reduce dal capoluogo dove aveva partecipato all'insurrezione.
Intanto, a Palermo il 2 febbraio seguente fu formato un governo provvisorio siciliano e il 28 marzo, dopo il ritiro dall'Isola dei Borboni, si costituì il Parlamento Siciliano, di cui fecero parte come deputati il terranovese Cav. Giacomo Navarra Navarra, in qualità di rappresentante del Comune, e i due concittadini Giuseppe Di Menza Vella e Tommaso Corvisieri in qualità di rappresentanti distrettuali. Altro deputato della zona fu Tommaso Masaracchio di Niscemi, il quale si era distinto durante le giornate della rivoluzione a Palermo contro l'esercito borbonico. Il Parlamento, dichiarata decaduta la dinastia borbonica, il 13 aprile 1848 conferì a Ruggero Settimo la reggenza dell'Isola in qualità di Presidente del Regno. Durante questo periodo, nei vari comuni dell'Isola si costituì la Guardia Nazionale, chiamata anche guardia civica, sull'esempio di quella già importata in Sicilia dai Francesi nel 1796: un corpo armato di cittadini reclutato all'interno dei comuni dell'Isola per mantenere l'ordine pubblico e difendere la pubblica libertà.
Anche a Gela prese vita, a partire dal 17 marzo del 1848, un corpo armato di cittadini composto da un battaglione di sei compagnie, ognuna delle quali era costituita da centonove militi, otto caporali, un foriero, quattro sergenti maggiore, un sergente e quattro graduati: un alfiere, un primo tenente, un secondo tenente e un capitano. Il battaglione era comandato da un Maggiore e da un Aiutante Maggiore. Le ultime due cariche a Terranova erano rivestite, rispettivamente, dal marchese di Torreforte Francesco Mallia e dal Cav. Giacomo Navarra Navarra. Affiancava questo corpo armato un Comitato di Difesa e Sicurezza pubblica. La situazione sociale a Gela grazie alle dette istituzioni si normalizzò, così, il 18 luglio, il Consiglio Civico, con a capo il presidente Carlo Navarra lacona (Primo cittadino), riprese la normale attività amministrativa.
Mentre nel Parlamento Siciliano si insediarono uomini provenienti dall'aristocrazia ma che comunque avevano partecipato da protagonisti ai Moti Siciliani, viceversa, la stragrande maggioranza degli altri aristocratici dell'Isola si pose a capo della Guardia Nazionale, dei comitati di difesa e delle civiche amministrazioni. Questa schiera di aristocratici era la stessa che prima aveva affiancato i Borboni, salvaguardando i propri interessi e privilegi a danno delle classi meno abbienti che soltanto con la fine del dominio borbonico avrebbero potuto aspirare ad una democratizzazione della vita pubblica, alla giustizia sociale e alla perequazione economica. Per questi aristocratici, neoconvertiti alla causa della rivoluzione, l'allontanamento dei Borboni assunse un'importanza particolare; non tanto perché la Sicilia diventò indipendente dal resto della Penisola ma perché, nella transazione di governo, poterono aspirare al consolidamento del loro dominio sociale ed economico. Infatti, se sotto i Borboni erano riusciti a salvaguardare la posizione elitaria, liberati dal controllo regio, pensarono di consolidare il loro stato di privilegiati.
Il nuovo Stato così nacque su basi ibride, per cui, già nel 1849 le profonde divergenze tra le masse popolari e i baroni si acuirono al punto tale da spaccare il fronte dell'unità rivoluzionaria, per cui, l'esercito isolano, nel maggio dello stesso anno, subì una dura sconfitta ad opera delle forze borboniche che rientrarono nell'Isola comandate dal Gen. Carlo Filangieri, principe di Satriano. Il 15 maggio i liberali a Palermo furono sanguinosamente decimati dalle truppe borboniche di Ferdinando II che di lì a pochi giorni, si rimpadronì di nuovo di tutta la Sicilia, instaurando un regime di polizia. Anche Gela, che nell'aprile del 1849 corse il rischio d'essere bombardata dalle navi del Filangieri, fortunatamente evitò il pericolo grazie all'azione di mediazione portata avanti dal concittadino Conte Angelo Panebianco.
I capi della rivolta pur perseguiti dal regime borbonico appena restauratosi, con l'azione mediatrice della diplomazia inglese, ebbero la possibilità di salvarsi; infatti 43 di loro, tra i più compromessi, pur di non sottostare nuovamente ai Borboni, preferirono espatriare dall'Isola prendendo la via dell'esilio a Malta. Tra gli esuli vi furono anche sei cittadini gelesi: Giuseppe Navarra, Giacomo Navarra Navarra, Gaetano Navarra Bivona e i tre fratelli Cammarata Scovazzo: Carmelo, Francesco e Lorenzo. I primi tre non ritornarono mai più a Terranova, nè in vita nè in morte. Il nostro Comune, tempo dopo, a ricordo di questi patrioti, murò una lapide nel vestibolo del vecchio Municipio. Questa lapide, con i nomi dei patrioti del 1848, assieme ad altre, andarono perdute per sempre (sic), verso il 1950, durante i lavori per la costruzione del nuovo municipio.

Francesco Camerata Scovazzo
CARTOLINA DI OGGI
Scena agreste con lo sfondo del Castelluccio
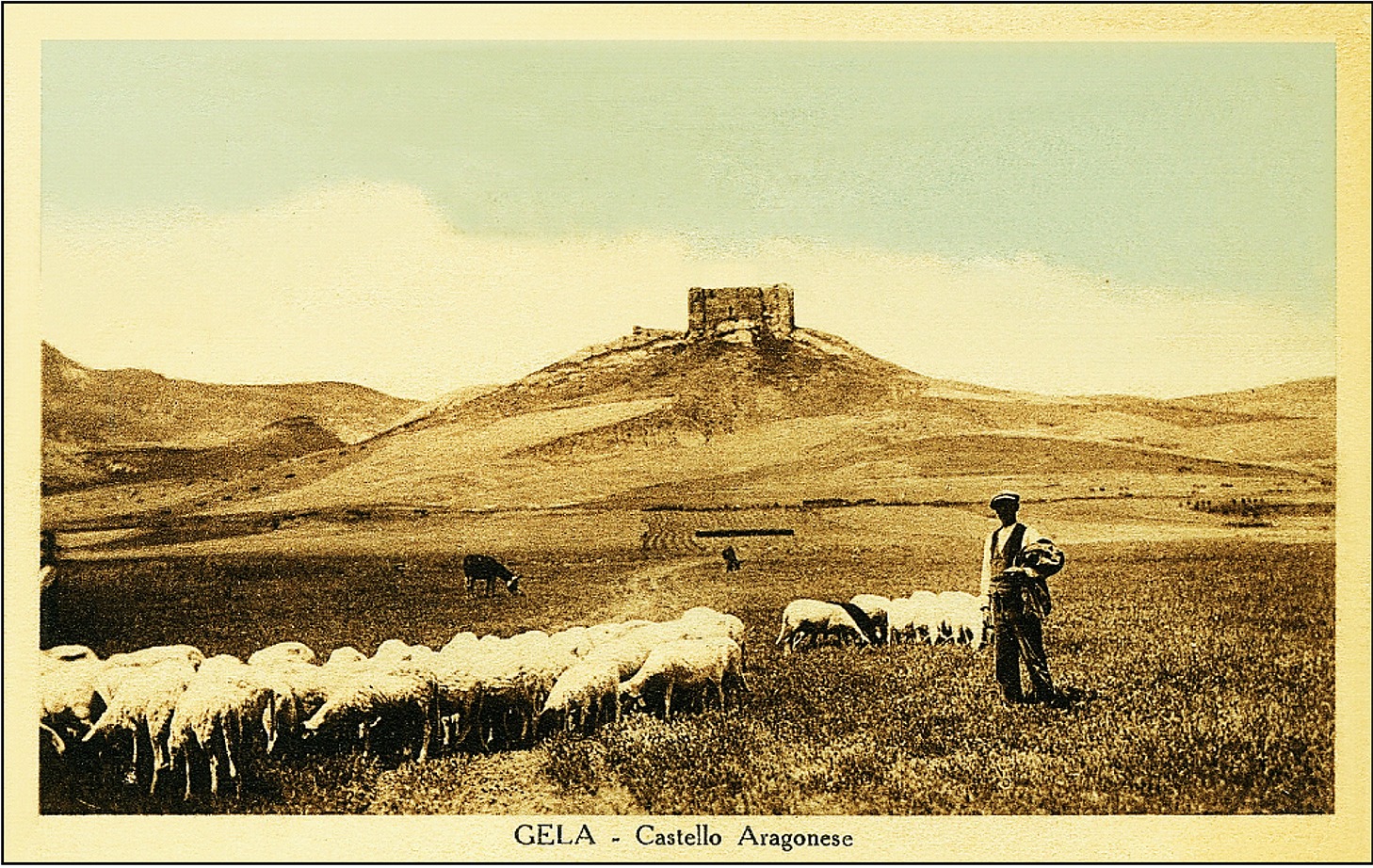
La cartolina degli
anni Trenta ci presenta il fortilizio del XIII
secolo,
denominato “Castelluccio”,
in contrada Cucinella Spadaro, distante 7
chilometri da Gela, inserito in
una scena agreste composta da una mandria di
pecore al pascolo sulla pianura e da un pastore
con lo sfondo dello stesso fortilizio in cui sul
lato destro s’intravvede un crollo della sua
parete.
Di pianta rettangolare
(lunghezza 30 m., altezza 12 m. e larghezza 11
m.) e a cielo aperto, il Castelluccio è
costituito da un pianoterra, da alcune finestre
e dai resti di un piano superiore forse mai
realizzato; l’interno era diviso da cinque archi
ogivali finalizzati a sostenere il soffitto; la
torre di ovest, usata al suo interno come
cisterna di acqua piovana, ne difendeva
l’ingresso.
Dopo diverse
vicissitudini, nella prima metà del XV secolo il
Castelluccio divenne residenza di un alto
funzionario governativo. Nel seconda metà del XV
secolo l’edificio fu abbandonato dopo un
incendio. Nei primi decenni del XVI secolo, il
Castelluccio fu sottoposto ad un consolidamento
che però fu improvvisamente interrotto, se ne
sconosce la causa, e mai più ripreso.
Nel restauro del
Castelluccio operato dalla Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Caltanissetta oltre alla
ricostruzione della parte di parete crollata,
a partire dal 1987
e fino al 1996
sono stati
effettuati degli scavi archeologici che hanno
evidenziato diverse fasi di vita. Il
Castelluccio, fu
aperto alla pubblica fruizione il 4 agosto del
1997; però, da quasi due decenni risulta
totalmente abbandonato dall’istituzione, in
preda al più feroce vandalismo e che ha visto
anche il furto di un pesante cancello oltre alla
devastazione totale della zona riservata agli
uffici.
Si parla da sempre
di un tunnel, addirittura percorribile da
cavalli, che dal Castelluccio arriva fino a
Gela, nel luogo degli ex Granai del Palazzo
Ducale, a ridosso dell’attuale grattacielo posto
all’angolo tra il Corso e Piazza Calvario;
certamente se fosse stato realizzato questo
tunnel di 7 km., data la sua complessità nel
realizzarlo, non sarebbe passato inosservato
alle cronache storiche di Gela. Ma non solo di
questo tunnel, si parla anche di altri che
collegano alcune chiese con dei palazzi nel
centro storico murato. Sono tutte fandonie.
Infatti, quando si è scavato per la posa di
condotte o per altri motivi sono state
evidenziate sempre vecchie fognature che hanno
dato origine a tali dicerie.
Sul retro della
cartolina, affrancata con un francobollo di 20
cent della serie “I BIMBI D’ITALIA SI CHIAMAN
BALILLA”, si leggono “Edit. Ditta Eugenio
Costa-Gela”, “Stab. Dalle Nogare e
Armetti-Milano”, “RIPR. VIET. - R.D.L. 7-X-1925
- N. 1960” e il testo del messaggio destinato al
“Dott. Guido Mangano, Via Siracusa 11, Palermo”
che recita: “A Lei ed alla sua … Signora,
distinti ossequi. Amalia Morso Elvira Morso -
Gela 9.11.32”.