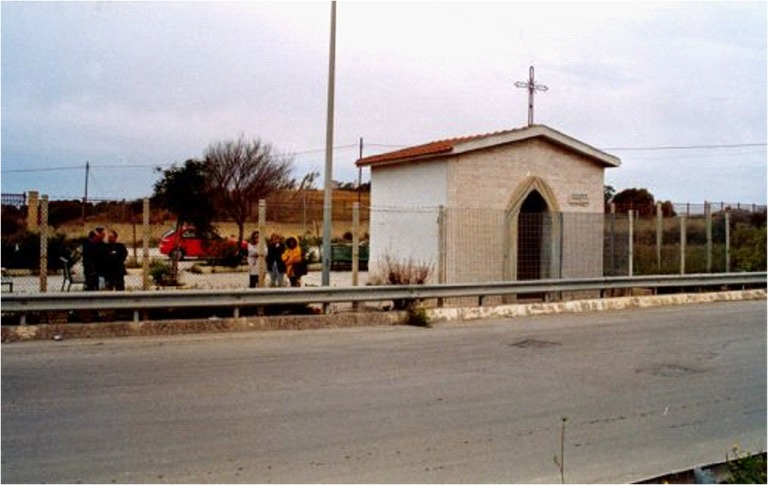ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GELA

L’archivio
comunale, importante componente della struttura
amministrativa locale, è costituito da una
raccolta d’atti e registri prodotta negli anni
dall’Amministrazione Comunale relativa
all’attività svolta per il raggiungimento dei
propri fini istituzionali e successivamente
conservata per scopi amministrativi o giuridici
o come fonte documentaria per gli studi storici.
Gli atti
amministrativi soggetti a frequente
consultazione e quindi relativi a pratiche che
ancora richiedono provvedimenti, sono conservati
nell’Archivio corrente,
mentre quelli che riguardano affari già conclusi
e quindi di consultazione più rara, sono
conservati nell’Archivio
di deposito;
invece spetta all’Archivio
generale
raccogliere e custodire tutti i documenti
relativi ad affari esauriti da oltre quaranta
anni. In definitiva l’archivio corrente e
l’archivio di deposito sono archivi
amministrativi, mentre l’archivio generale
rappresenta l’Archivio
storico del Comune,
ovvero una testimonianza preziosa della vita di
una comunità, dove gli atti trovano una
definitiva sistemazione e rimangono a perpetuare
nel tempo memorie della passata attività
dell’amministrazione comunale.
Nel temporaneo
trasferimento di tutti gli uffici del Comune al
Convitto Pignatelli, durante la costruzione del
nuovo Palazzo di Città alla fine degli anni
Quaranta, non tutti gli atti dell’archivio vi
furono trasportati; infatti, buona parte di
essi, fu portata nei locali dell’ex Lazzaretto
(già Convento dei PP. Agostiniani, oggi sede
della Biblioteca Comunale), dove fu accatasta in
una stanza e lì rimase, sicuramente dimenticata
per indolenza, anche dopo il rientro degli
uffici comunali nel nuovo edificio. Siamo agli
inizi degli anni Cinquanta.
Ma anche quella
parte d’atti dell’archivio che rientrò nel nuovo
Municipio non fu tutta depositata nell’archivio
di deposito che oggi è ubicato in uno stanzone a
pianterreno sotto la torre dello stesso
Municipio con ingresso in Viale Mediterraneo;
infatti, i faldoni contenenti le carpette con
gli atti più vecchi furono accatastati alla meno
peggio in uno stanzone al secondo piano
prospiciente la scala secondaria di accesso al
Municipio di Viale Mediterraneo; lo stanzone
angusto e con una sola finestra che si affaccia
sul cortile della ex Pretura, era utilizzata,
però, anche come deposito di diverso materiale,
persino oggetti di sequestri effettuati dai
Vigili Urbani.
Intanto verso la fine del 1983 essendo stati
appaltati i lavori per la ristrutturazione
dell’ex Lazzaretto si dovettero sgomberarne i
locali; così gli atti, contenuti in sacchi di
canapa, depositati trent’anni prima, furono
prelevati e, coperti da un precario telone di
plastica, accatastati come se fossero stati
sacchi di spazzatura sul piazzale dietro la
chiesetta di San Biagio, all’ingresso del
contiguo cimitero con il risultato che, in
seguito ad un acquazzone, buona parte di essi
andò in rovina; quel che rimase di salvabile
dell’antico archivio fu trasferito, purtroppo
ancora umidiccio, nei locali Iannizzotto,
ubicati sulla statale 115 per Vittoria, di
proprietà del Comune.
Anche qui tale materiale non ebbe sorte migliore
del precedente; infatti, fu malamente depositato
e chiuso in uno stanzone adibito tempo prima a
cella frigorifera e quindi senza nessuna
areazione.
Nel seconda metà
del 1985 la stanza a secondo piano del
Municipio, che conteneva quella parte più antica
dell’archivio storico, fu svuotata per essere
adibita ad altra funzione; tutti i faldoni così
furono prelevati, messi in grossi sacchi neri di
plastica utilizzati per la spazzatura e
temporaneamente trasferiti in una stanza a piano
terra a lato della torre del Municipio con
ingresso dal Viale Mediterraneo, in attesa di
essere destinati al macero, cosa che non avvenne
per interessamento dello scrivente, avvisato in
tempo dall’impiegato comunale Sig. Fino Raniolo,
allora responsabile dell’Ufficio Protocollo.
Successivamente,
nel marzo del 1986, allo scrivente, da parte
dell’allora assessore
Tommaso Camilleri, fu
dato l’incarico di reperire tutto il materiale
d’archivio della suddetta stanza e trasferirlo
nei riattati locali a pianterreno dell’ex
lazzaretto del convento agostiniano, che da lì a
qualche anno sarebbe diventato sede della
Biblioteca Comunale, dove, dopo una radicale
bonifica, il materiale cartaceo subì una prima
temporanea catalogazione.
Nel 1988, da parte
dell’Amministrazione comunale fu affidato allo
scrivente il compito di riordinare, catalogare
ed inventariare gli atti dell’archivio. Il
lavoro dell’Archivio Storico, effettuato su
direttiva e supervisione dell’allora Direttore
dell’Archivio di Stato di Caltanissetta Dott.
Claudio Torrisi, nonché col beneplacito della
Soprintendenza ai Beni archivistici di Palermo,
fu consegnato il 22 settembre 1994; inoltre, per
tale lavoro
fu prezioso l’aiuto del
personale della Biblioteca, in particolare dei
funzionari Rag. Vincenzo Tranchina caposezione,
Sig.a Salvina Blanco, Sig.a Maria Di Bartolo e
di quello ausiliario con i Sigg. Michele Gammino,
Benito Faraci e Augusto Tignino.
Alla relazione di tale consegna furono allegati
due indici relativi a 628 carpette; uno
realizzato sulla base del numero di corda ad uso
del personale, l’altro costituito sulla base
degli estremi cronologici, che vanno dall’Unità
d’Italia (ma anche prima) fino agli anni
Cinquanta, ad uso dell’utente; sono state
consegnate anche 628 schede di consultazione,
corrispondenti al numero delle carpette,
contenenti riferimenti analitici sul contenuto
delle stesse.
Le 628 carpette,
infine, si riferiscono pure a diversi registri
decurionali, dal 1820 al 1873 contenuti in tre
carpette, e 13 fascicoli d’Atti Giurati dal 1582
al 1595 conservati in due carpette; queste
cinque carpette sono state contrassegnate con le
lettere dell’alfabeto. Il testo, di difficile
grafia contenuto negli atti cinquecenteschi, è
per la maggior parte scritto in latino, anche se
non mancano diversi fogli scritti in antico
vernacolo, e si riferisce ad atti di donazione e
successione ma anche a direttive degli stessi
Giurati.
Qualche decennio
fa l’archivio storico è stato arricchito di
altre 130 carpette di atti del periodo fascista,
ancora non completamente catalogati, prelevate
dall’archivio di deposito del Municipio dove
ancora ne esistono qualche centinaio.
Un altro corposo
archivio corrente del Comune di Gela, di cui non
si danno notizie perché non ancora attenzionato
dallo scrivente, si trova nei locali comunali di
via Marsala nel Settore 4 - Urbanistica e
Patrimonio.
Anche se
l’archivio storico del Comune di Gela ha subito
negli anni un consistente depauperamento, sia
per alcuni fatali incendi (uno dei primi di cui
si ha notizia fu quello del 6 dicembre 1864),
sia per l’incuria di dirigenti e amministratori,
non si nasconde la viva soddisfazione dello
scrivente nell’aver promosso e contribuito in
modo determinante a salvare due secoli di storia
recente della vita della nostra città che
diversamente sarebbero andati perduti perché
…indolentemente e ignorantemente già destinati
al macero.

Cartolina di oggi
L'OSPIZIO MARINO PER PAMBINI SCROFOLOTICI E RACHITICI
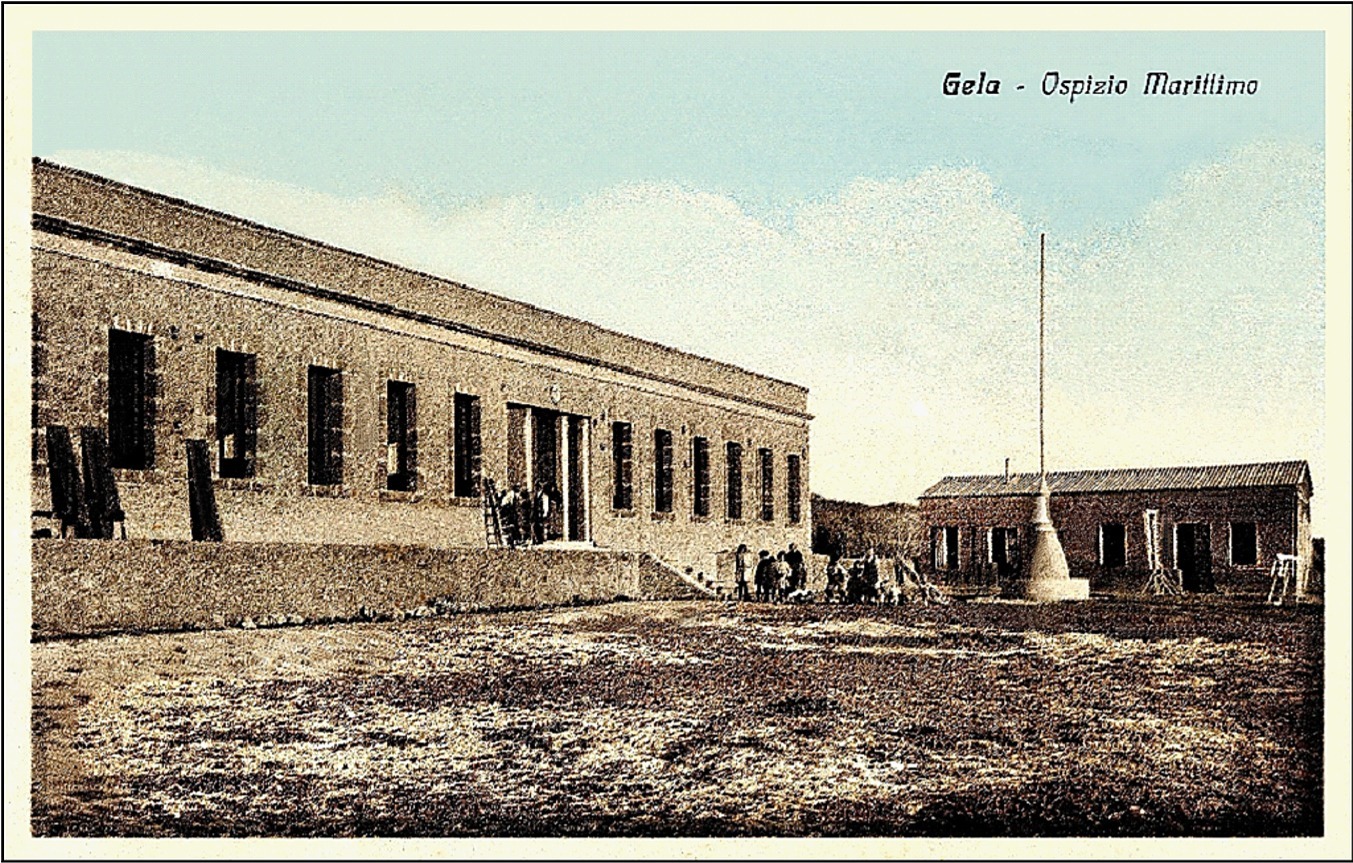
La cartolina,
formato 9X14 cm., risalente agli anni Trenta
ritrae l’Ospizio Marino (definito erroneamente
nella didascalia come Ospizio Marittimo),
costituito allora solamente da due edifici;
costruito intorno al 1930 su progetto di tale
Ing. Cavalieri, era amministrato, fin dalla sua
fondazione avvenuta sulla carta dieci anni
prima, dal C.d.A. dell’Ospedale Civile.
L’Ospizio ospitava bambini di ambo i sessi, dai
6 ai 15 anni, per la cura della scrofolosi e del
rachitismo; agli stessi bambini, inoltre, erano
offerti vitto, alloggio, cure, medicature e i
mezzi per frequentare i bagni a mare. Quindi un
centro termale vero e proprio dove inoltre
venivano applicate l’elioterapia, la
talassoterapia e la psammoterapia.
La gestione
dell’Ospizio fu affidato alle Suore Figlie di
Sant’Anna e all’opera indefessa del Dott.
Filippo Solito, grande benefattore, che
provvidero inoltre ad ampliare la struttura con
la costruzione di altri due padiglioni. Ai
funerali del Dott. Solito nel 1941
l’On. Salvatore Aldisio, nel suo discorso
funebre ebbe ad usare le parole più amabili
all’indirizzo del defunto, definito “mitico
amico”; disse tra l’altro, “…Filippo Solito
prodigò tutto l’essere suo in una intensa febbre
di lavoro che si trasformava di giorno in giorno
in un altissimo apostolato; egli fu il dottore
per antonomasia… la sua casa divenne la casa dei
poveri ai quali con la delicata discrezione dei
grandi apostoli della carità soccorreva e
profondeva ad essi nulla potevano dargli, altro
che la soddisfazione di sollevare dolori e
miserie ed essergli grati e benevolenti… se solo
si potesse mettere in cifre il numero dei malati
da Lui operati, curati e soccorsi, ciò solo
rappresenterebbero un immenso debito acceso
sulla riconoscenza della nostra Città… la sua
attività filantropica si estese a tutte le opere
locali di assistenza medica…”.
All’inizio degli
anni Sessanta l’Ospizio Marino chiuse i
battenti; i suoi locali furono successivamente
occupati da diverse scuole, ultima quella
dell’ex Istituto Magistrale. Abbandonato per
diversi decenni, nell’ottobre del 2010 l’Ospizio
Marino di proprietà dell’Unità Sanitaria locale
fu diroccato per realizzare un Centro di
Radioterapia, entrato in funzione nel 2013, che
poi fu dedicato al compianto Crocifisso Moscato.
Tuttora nell’area
a sud del Centro esiste ancora un sottopassaggio
che porta direttamente sulla spiaggia e che
serviva ai piccoli ospiti di una volta per
raggiungere i casotti disposti sulla sabbia dopo
la costruzione del lungomare; ma non è il solo,
un altro sottopasso esiste più a est a confine
con Bosco Littorio, dietro quella che una volta
era l’area dove era ubicato un distributore di
carburanti, sottopasso trasformato impunemente
in uno scriteriato canale di scolo.
Il messaggio della
possibilità di riproporre a Gela un centro
termale, che diverse volte è stato inviato ai
nostri politici, non ha sortito nessun effetto
…e chissà per quale motivo.
Sul retro della
cartolina, con un francobollo malamente
asportato, si leggono “Eugenio
Costa - Gela - Ripr. viet.”,
la destinazione “Preg. Sig. Carlo Mercaldo R.
Prefettura, Trieste” e il testo dei saluti che
recita: “Ringrazio
Sentitamente, Nunziatina Di Bartolo. Gela
23/3/1933”.
.jpg)
Non si è riuscito mai a sapere il perché del cambio del toponimo di via Spirone in Via Pisa, effettuato da una Commissione di toponomastica dei decenni passati, anche perché su tale antico toponimo c’è dietro tutta una storia che vale la pena raccontare sinteticamente.
Innanzitutto in merito al toponimo “Spirone”, denominato dai terranovesi almeno due secoli fa al quartiere a ovest del Municipio (compreso tra le vie Giacomo Navarra Bresmes e Morello e limitato da via Cairoli), bisogna rifarsi al traffico commerciale marinaresco dell’Ottocento tra Gela e Malta che era effettuato con dei bastimenti denominati in vernacolo “spironare” o “xprunare”.
Il termine, derivato dalle antiche navi romane speronare ma che in questo caso si riferiva a navi veloci e di basso pescaggio, si atteneva alla presenza di un falso sperone al di sopra del tagliamare come rinforzo della ruota di prua; le dimensioni delle speronare andavano dai 14 a 15,5 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza con un pescaggio a pieno carico di mezzo metro, mentre da scarica la barca pescava di 1,20 metri.
Nel 1859 si sa che in Sicilia vi erano 21 speronare secondo una statistica ufficiale del Regno delle due Sicilie; 11 di esse facevano parte del compartimento di Siracusa e 4 in quello di Messina. Dopo l’Unità d’Italia la statistica ne riporta 35 di cui 30 nella sola Porto Empedocle. Le speronare possedevano uno, due o tre alberi con vela triangolare o latina, e potevano portare uno o più fiocchi montati a prua davanti all'albero. Dalle Poste di Malta nel 1982 furono emessi quattro francobolli con le immagini di diverse antiche navi tra cui compare quella di una “xprunara”. L’impiego di queste barche era riferito al trasporto di merci e passeggeri, quindi in dialetto navi “spironare” o “xprunare” e i cui marinai, definiti giustamente come “spirunari”, abitavano in un quartiere dentro le mura di cinta che si affaccia a mare, denominato appunto “spuruni” (ovvero “Spirone”) in quanto quartiere dei “spirunari”. Riguardo al particolare dialetto gelese utilizzato dagli abitanti di questo quartiere, esso possedeva delle varianti ed una particolare caratteristica di cantilena che lo contraddistingueva da tutti gli altri quartieri della città.
Riguardo la denominazione di via Pisa, come già detto più sopra, sostituita a suo tempo a via Spirone da una commissione consiliare di toponomastica, lo scrivente da tempo si è arreso nel cercare di capire il nesso tra i toponimi “Spirone” di allora e “Pisa” di oggi; però, nulla vieta che qualcuno abbia avuto la sfacciataggine e la tracotante ignoranza di paragonare il quartiere “Spirone” ad una repubblica marinara toscana, cioè …la città di Pisa.