Cartolina di oggi
UNA COLONNA DORICA, UNICA SUPERSTITE DI UN'ATAVICA FEROCIA
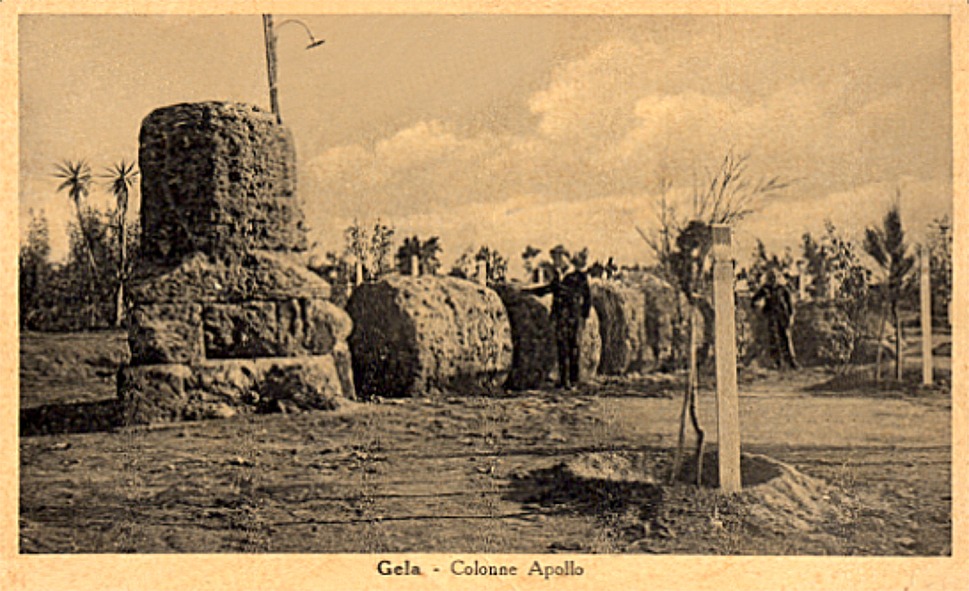
La cartolina di oggi risalente agli anni Venti, formato 14X9 cm. e di color seppia, raffigura i rocchi della colonna dorica scomposta nell’area di quel che poi nel 1927 diventò il Parco delle Rimembranze. La colonna quand’era ancora in piedi fu seriamente danneggiata durante il terremoto in Sicilia del 1693; ricomposta e rialzata una prima volta, nel 1750 fu riabbattuta a causa di un fortissimo vento. Fu rimessa in piedi ulteriormente nel 1951 ed è rimasta così come la si può vedere oggi. La cartolina viaggiata con quattro francobolli di £. 5 della serie “Mestieri Italiani” con la raffigurazione di un lavorante toscano al tornio (francobollo raro valutato a seconda delle condizioni in cui si trova dalle 200 alle 800 euro); sul retro della cartolina oltre alle scritte “Ed. Costa luigi - Emporio - Gela” e “Stab. Delle Nogare e Armetti - Milano” sono riportate in una grafia illeggibile il destinatario e i saluti del mittente. Non c'era riuscito nemmeno Phinzia, nel 282 a.C., a radere completamente al suolo Gela, cosa che invece riuscirono a fare gli stessi gelesi (allora Eracleensi) a partire dal 1233, quando fu fondato sul sito dell'antica Gela il castello federiciano di Heraclea. Fame di Pietra, fame di case, un atavico binomio che dopo più di settecento anni doveva portare la nostra città a diventare la capitale internazionale dell'abusivismo edilizio e, grottescamente, una delle città con un rapporto vano-abitante maggiore di quello dei paesi nordici.
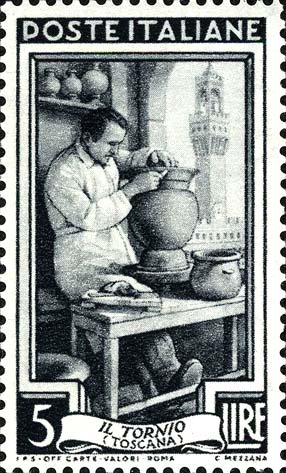
Dalla feroce distruzione tardo-medievale si salvò miracolosamente una sola colonna dorica appartenente all'opistodomo del tempio di Athena del 480 a.C., forse per l'arcano destino di perpetuare, quasi a voler sfidare l'eternità, il ricordo di una civiltà classica, da cui deriva, che espanse la sua potenza e la sua cultura dorica in quasi tutta la Sicilia; questa popolazione gelese (in particolare la classe politica) che oggi, ma già da più di mezzo secolo, non riconosce più le sue origini avendole rinnegate con l'illusione industriale.
Oggi la colonna dorica è
ancora lì, nel Parco delle Rimembranze, un’area
verde smantellata alla fine degli anni Ottanta
dal “duca Ernesto” prima e successivamente dalle
varie ”duchesse” che si sono succedute nella
gestione delle soprintendenze; e purtroppo dopo
quasi mezzo secolo ancora non ridata alla
fruizione popolare. Inserita nel sito
dell'acropoli di Gela antica, la colonna dorica
sembra in “isolamento” a combattere e resistere
per la sua sopravvivenza contro l'aria una volta
ammorbata dalle esalazioni putride e venefiche
del vicino petrolchimico da tempo dismesso. E
ci è riuscita; ad essa gli sta vicino un fante
di bronzo, a ricordo dei terranovesi Caduti
nella Grande Guerra, “impassibile”, quasi a
volerci ammonire, oggi maggiormente, che l'amor
patrio è una cosa imprescindibile per il
patrimonio spirituale di una civile popolazione
e che per salvaguardarlo si paga anche con
l'olocausto della vita. Parole oggi declamate a
vuoto. Chi volete che ci creda più…
I pionieri dell’Archeologia
e il turismo archeologico di Gela
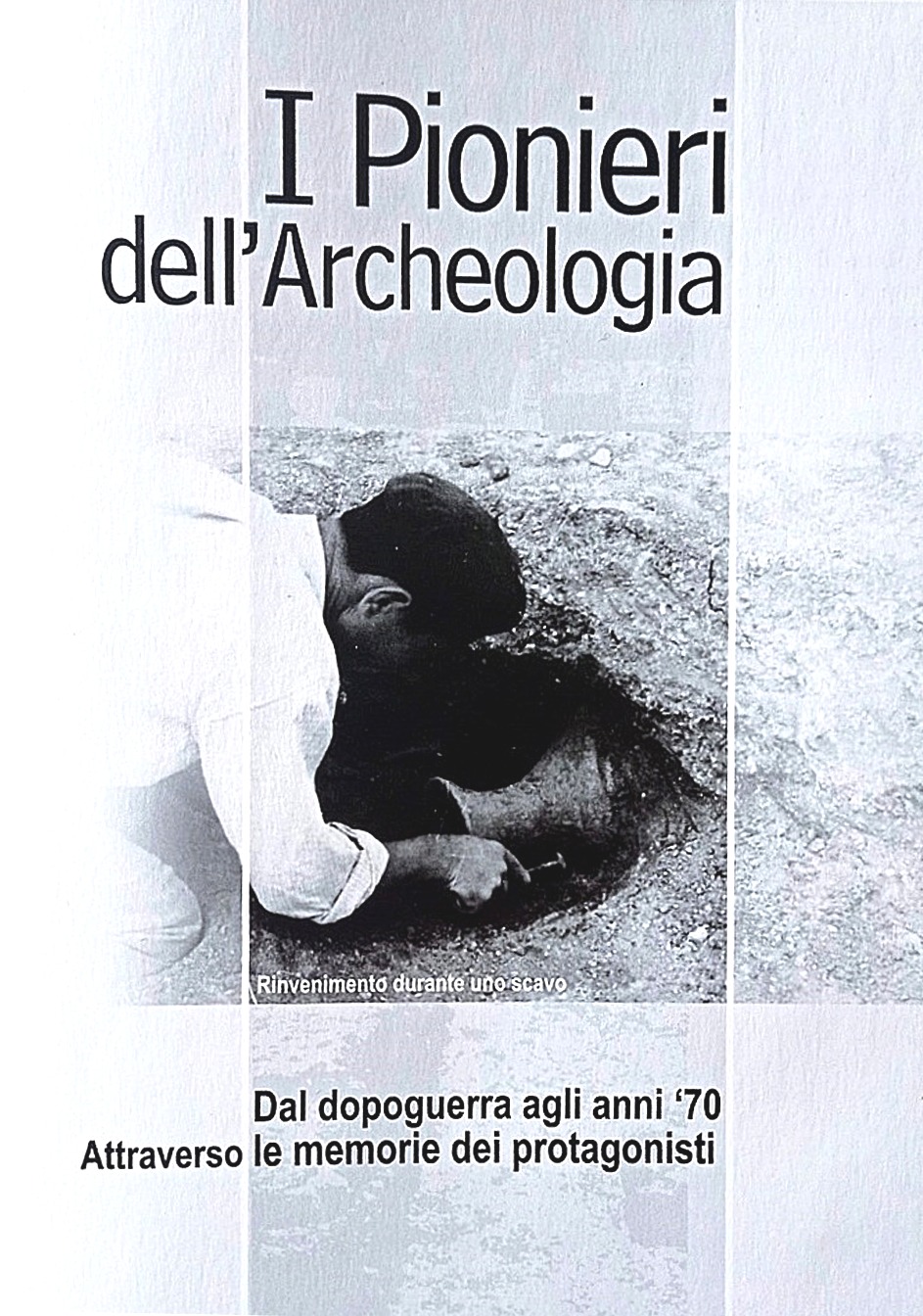
La manifestazione "I
pionieri dell'archeologia, dal dopoguerra agli
anni 70 attraverso le memorie dei protagonisti"
presentata prima a Caltanissetta e poi a Gela,
domenica 6 aprile 2003, nei locali degli ex
Granai del Palazzo Ducale dall'allora Assessore
provinciale al turismo Enrico Ascia, al di là
del fatto che fece rivivere determinati aspetti
esaltanti dell'archeologia e delle sue scoperte
attraverso le parole e l'esperienza dei
protagonisti, rappresentò a nostro modo di
vedere un momento importante per iniziare a
ridisegnare e a ridiscutere un modello di
sviluppo di uno dei fattori che contribuiscono
ad incrementare l’economia e l’occupazione di
una comunità. Parlare d'archeologia e far
parlare coloro che dal sottosuolo evidenziarono
questi giacimenti culturali, in realtà ci rese
partecipi di un dibattito più ampio sulle
risorse archeologiche dal punto di vista della
rinascita del turismo archeologico nel nostro
territorio; sono tante le nostre risorse
archeologiche e non esageriamo a dire che forse
ancora il meglio dovrebbe venire in quanto ci
sono vaste aree, tipo il Bosco Littorio e
l’Acropoli, che ancora devono essere continuate
a scavare. E fossero solo queste; l’area a nord
delle fortificazioni greche, che aspetta di
essere scavata dal 1948, i complessi
protostorici dell’età del Bronzo di Disueri e di
contrada “I
Lotti” a
Manfria, dove esistono ancora centinaia di tombe
da esplorare, l’area di Bubbonia, sotto
Mazzarino, e così via; tutte zone senza nessun
controllo da parte della Soprintendenza e da
tempo appannaggio di spietati tombaroli.

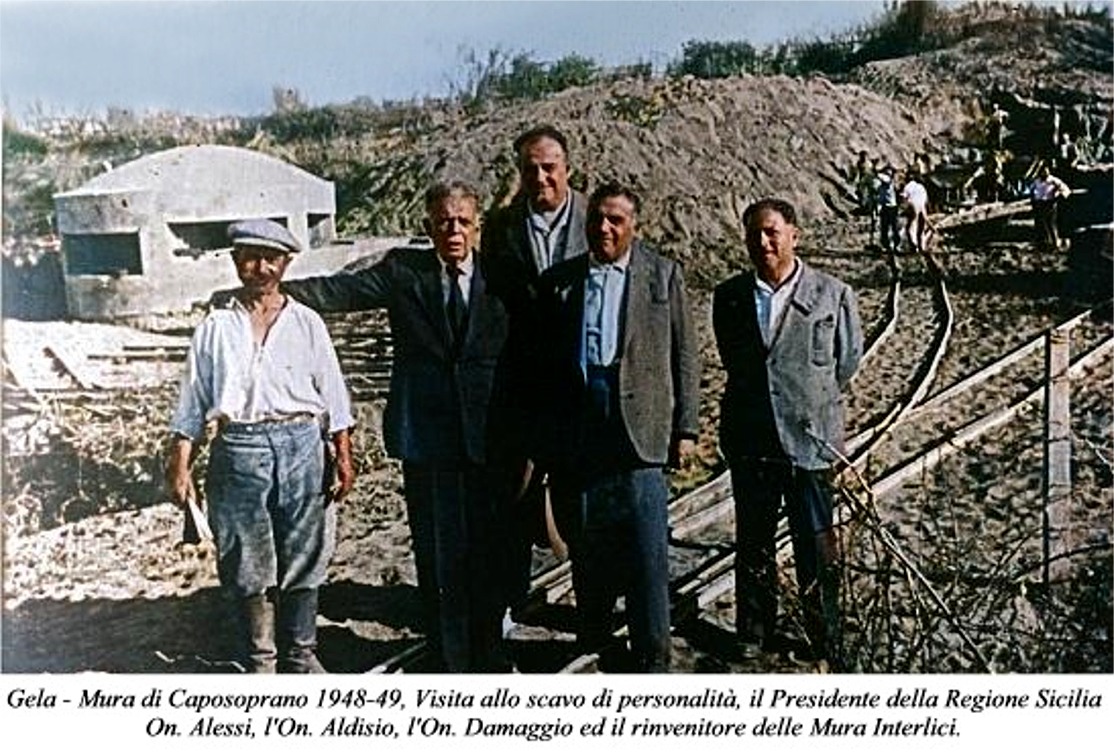
Nella
manifestazione di allora si notò l’assenza del
Presidente della Provincia e dei dirigenti della
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta
sicuramente contrariati a partecipare chissà per
quale recondito (mica tanto) motivo; nello
stesso convegno una valida testimonianza fu
data, oltre che dal dott. Enrico Ascia,
dall’archeologa Enza Cilia Platamone, da Valeria
Fichera, presidente dell’associazione “Sicilia
musei”, dalla medievista Prof.ssa Salvina
Fiorilla e dall’Archeoclub di Gela con il Prof.
Nuccio Mulè. Per l’occasione fu anche stampata
una pubblicazione dal titolo
“I pionieri
dell’Archeologia” edita dall’Assessorato al
Turismo della Provincia regionale di
Caltanissetta e dall’associazione “Sicilia
musei”; tale
pubblicazione riportò
anche i ricordi, il curriculum e la bibliografia
di Pietro Griffo, Dinu Adamesteanu, Pietro
Orlandini, Ernesto De Miro e Graziella
Fiorentini.
Oggi a Gela e nel
suo comprensorio esistono una trentina di aree
archeologiche tra quelle protostoriche, greche,
romane e medievali di grandi e piccole
dimensioni; ma solo tre di esse (fortificazioni,
bagni greci e acropoli) sono praticamente
fruibili e non sempre in modo continuato; oggi
per esempio per visitare le fortificazioni
greche di Capo Soprano bisogna contattare il
Parco Archeologico di Gela via email o
telefonicamente per prenotare una sua visita. E
ciò senza considerare tutti quegli scavi
archeologici, effettuati su ritrovamenti
casuali, che nei vari decenni sono stati
realizzati nel centro storico. Senza
dimenticare, inoltre, il recupero e la
musealizzazione dei resti delle navi greche
ritrovate nei fondali del mare di Bulala; i
resti lignei della prima nave furono ritrovati
nel 1989, ben 36 anni fa e ancora, nonostante
che il museo delle navi di Bosco Littorio sia
stato realizzato, sono ancora chiusi in casse
depositate nel Museo archeologico locale, ancora
chiuso alla fruizione dal 2021 per
ristrutturazione.
Si scriveva di
fruizione, ma aree archeologiche fruibili da
chi? Non sappiamo di preciso quale è la presenza
turistica qui a Gela ma non siamo lontani dal
vero nel dire che essa è praticamente a quota
zero o quasi zero, dato desumibile dai numeri
ufficiali di visitatori forniti dalla Regione
Siciliana. Che rabbia, però, vedere i torpedoni
dei turisti esteri e nostrani che da Agrigento
vanno a Piazza Armerina e Caltagirone e da lì
direttamente nel Ragusano saltando di fermarsi a
Gela, almeno per mezza giornata; e ciò non
accade perché il numero delle strutture
ricettive a quanto sembra lascia a desiderare.
Diciamolo con
franchezza: siamo tagliati completamente fuori
dagli itinerari turistici isolani, addirittura
ci si dimentica pure di citare la nostra città e
peggio ancora si consiglia in qualche sciagurato
caso di non visitarla. Arriviamo al grottesco
poi, quando dicono che qui non abbiamo nulla che
valga la pena di visitare. Quanti bocconi amari
si sono ingoiati!
Cari signori
amministratori e cari dirigenti della
Soprintendenza ai BB.CC. di Caltanissetta datevi
seriamente una mossa, non si può e non si deve
più rimandare. E arrivata l'ora di far fruttare
i ritorni economici e occupazionali di quello
che si è speso e si sta spendendo anche se poco
e saltuariamente, comunque milioni e milioni,
per portare alla luce le vestigia del nostro
passato; anche se negli ultimi anni, grazie
all’archeologia preventiva, gli oneri degli
scavi sono a carico della stazione appaltante
ovviamente sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente
competente.
Fino ad oggi, ed è
bene scriverlo, le scoperte archeologiche hanno
fatto solamente la gioia degli archeologi per le
loro pubblicazioni e i loro titoli accademici; e
non lo diciamo in senso negativo, anzi che ben
vengano. Però, di altro si è visto poco. Cari
signori politici, prima regionali e poi locali,
se non si riesce a far decollare il turismo
archeologico a Gela allora è meglio,
metaforicamente parlando, risotterrare il tutto
e lasciare alle prossime generazioni il compito
di far fruttare questi nostri giacimenti
culturali. In merito poi alla presenza di
importanti strutture di archeologia bellica, che
potrebbero dare a Gela ritorni economici non
indifferenti, in particolare nel ricordare lo
Sbarco Alleato a Gela del 1943, ne tratteremo in
seguito
Comunque, ritornando
alla suddetta manifestazione dei pionieri
dell’archeologia del 2003, successivamente nel
tempo ne sono seguite altre anche di pregnante
rilievo, ma visti i risultati che fono ad oggi
ne sono derivati in termini di irrilevante
conseguenza numerica sulla fruizione turistica,
hanno lasciato purtroppo anch’esse il tempo che
trovano.
L’EPIDEMIA DI COLERA NEL 1911 A GELA
.jpg)
Tempo fa lo
scrivente, tra un’infinità di carteggi
dell’Archivio Storico del Comune di Gela, trovò
casualmente una breve relazione introduttiva
risalente al 1912 a firma del Sindaco dell’epoca
Avv. Antonino Giurato (1874-1936), riguardante
un’epidemia colerica comparsa a Gela nell’estate
del 1911, in cui si legge tra l’altro un
importante ed inedito spaccato delle condizioni
igienico-sanitarie della città. L’Avv. Giurato
assunse la carica di Sindaco il 12 agosto 1911
per concluderla il
2 dicembre del 1913. L’epidemia di colera di
quell’anno imperversò dal mese di giugno a
quello di dicembre
per poi diminuire e sparire grazie all’azione di
un adeguato intervento sanitario.
La mortalità di
allora raggiunse la media del 52,70% degli
ammalati soprattutto per il fatto che la maggior
parte di essi arrivava all’isolamento quasi
agonizzante. In totale da giugno al dicembre del
1911 i casi accertati di colera furono 268
(batteriologicamente n. 182, clinicamente n. 86)
con un totale di 183 morti. Il colera a Gela,
sempre nel periodo giugno-dicembre di
quell’anno, riguardò maggiormente le persone tra
30 e 40 anni e i bambini tra 0 e 5 anni con
prevalenza delle femmine con 153 casi rispetto
ai 115 dei maschi. Prima del 1911 il colera si
presentò in modo funesto nella nostra
popolazione per ben tre volte,
nel 1837, 1854 e nel
1867.
.jpg)
Senza togliere e
aggiungere niente, qui di seguito si trascrive
il contenuto della suddetta relazione del
Sindaco Avv.
Antonino Giurato:
“Sappiamo
tutti che esso manca di buona acqua potabile, e
che non è provvisto di un sistema razionale di
smaltimento dei residui della vita; in quanto
poi ai servizi di disinfezione vi si provvede in
modo imperfetto, per mancanza di personale ad
hoc, appositamente istruito e preparato.
Era perciò
necessario adottare provvedimenti che valessero
a migliorare, per quanto fosse possibile le
condizioni generali d'ambiente, e per
l'approvvigionamento idrico, escogitare tutti i
mezzi per garentirlo da inquinamento.
In quanto allo
smaltimento delle materie fecali, per evitare
che si continuasse nel deplorevole sistema di
riversarle sulla superficie stradale, furono
costruite delle latrine da campo alla periferia
dell'abitato e fu aumentato il numero dei carri
botti.
Fu intensificato
il servizio di nettezza pubblica. Fu provveduto
per un'oculata vigilanza sugli spacci di generi
alimentari. Si acquistarono una pompa igiea;
delle lampade a formalina, ed una buona scorta
di disinfettanti. Furono scelti i locali
occorrenti pel lazzaretto e per la casa
contumaciale.
Mancava soltanto
l'arredamento, perché l'Amm.ne del tempo era
convinta che per l'anno 1910, dato che i primi
casi di colera si erano avuti in Palermo verso
la fine di settembre, si sarebbe facilmente
evitata l'invasione del morbo nella città nostra
(ciò che difatti ebbe a verificarsi), e perché
l'Amm.ne parimenti reputava che sarebbe stato
facile provvedersi sul luogo di tutto
l'occorrente, ove se ne fosse sperimentata la
necessità.
Sopravvenuto
l'inverno, le condizioni sanitarie della Città,
che si erano già mantenute eccellenti,
continuarono ad esserlo, e tali seguitarono in
primavera e in estate.
Però i timori
della ripresa dell'epidemia, che si erano
manifestati nell'anno precedente, ebbero pur
troppo ad avverarsi nel 1911 in cui l’infezione,
dai centri maggiori dell'Isola, si irradiò negli
altri, seminando ovunque il terrore e la morte.
Verbicaro e Belmonte
Mezzagno, sono l'indice di uno stato d'animo,
mantenutosi inalterato malgrado 50 anni d'unità
e di tanta luce di progresso e di civiltà!
E ancora la grande
aberrazione, frutto della più crassa ignoranza,
che immola le sue vittime in un impeto di follia
collettiva!
II popolino si
crede avvelenato e si rivolta, incendia, uccide,
devasta; aggrava le condizioni miserevoli in cui
si trova; respinge la profilassi, ed agevola la
marcia vittoriosa del morbo, che s'asside sulle
rovine fumanti provocate dalla superstizione!
Era un monito, che
non andava trascurato. Il morbo continuava nella
sua marcia e la disposizione degli animi del
popolo minuto in Sicilia non affidava per
l'avvenire che si faceva quanto mai minaccioso.
L'Amm.ne al
potere, comprese che non vi era da indugiare, e
perseverando nelle misure di profilassi
adottate, pubblicò l'ordinanza sindacale 21
giugno 1911, riflettente i depositi
d'immondizie; l'obbligo delle disinfezioni
giornaliere delle latrine e lo espurgo dei pozzi
neri; l’imbianchimento con latte di calce dei
locali di spaccio di generi alimentari; il
divieto d'innaffiare gli orti con acque
cloacali; di asportare o trafugare oggetti
provenienti da abitazioni dove si fosse
verifìcato qualche caso di malattia sospetta
ecc. ecc.
Contemporaneamente
fu indetta dal Sindaco una riunione dei medici
condotti e liberi esercenti con l'intervento
dell'Ufficiale sanitario e della Giunta
Municipale, per discutere in merito ai locali
d'isolamento ed osservazione.
Fu ventilata
l'idea di costruire apposito baraccamento, anzi
il D.r Solito assunse l'incarico di redigere una
relazione in proposito, che insieme col verbale
di seduta, fu poi trasmessa alla R. Prefettura,
per ottenere la necessaria autorizzazione alla
spesa, che, come era facile prevedere, sarebbe
riuscita non indifferente.
Nel frattempo, il
24 luglio 1911, intervenne la morte del mio
compianto predecessore, Cav. Uff. Navarra, e,
per dolorosa necessità, gli affari dovettero
subire una certa remora fino a che non si
procedette alla nomina del nuovo Sindaco.
La
quistione perciò rimase insoluta e quando
assunsi il potere trovai, come dissi, che la
scelta del lazzaretto e della casa di
osservazione rifletteva il convento di S. Nicola
Tolentino al Caposoprano, e l'ex convento S.
Agostino.
Oltre
all'arredamento occorreva provvedere al
personale d'assistenza: medici, infermieri; e di
servizio, cucina e lavanderia.
Queste le
condizioni da me trovate, quando nel 12 agosto
1911 assunsi la carica di Sindaco.”.
A proposito di
quanto si legge sopra nella relazione riferito
ai “carri botti”; nei tempi passati, prima
dell’impianto della fognatura cittadina, il
nostro Comune istituì un servizio di quartiere
con dei carri che portavano sopra delle botti
per la raccolta “…delle acque luride e di
rifiuto” e delle deiezioni prelevate dai cantri
casa per casa, con il conduttore dello stesso
carro che avvisava del suo arrivo le persone con
una trombetta, era il cosiddetto “ ‘u patruni da
merda, passa”, frase che è rimasta nella memoria
dei gelesi per definire un tizio presuntuoso.
Nel 1854 la
popolazione siciliana fu interessata da
un’epidemia di colera che
causò circa 45mila vittime, mentre
l'ultima importante
epidemia di colera in Italia avvenne in Campania
e in Puglia nel 1973
anche se successivamente nel 1994 a Bari si
verificò un'epidemia di limitate proporzioni con
casi sparuti.
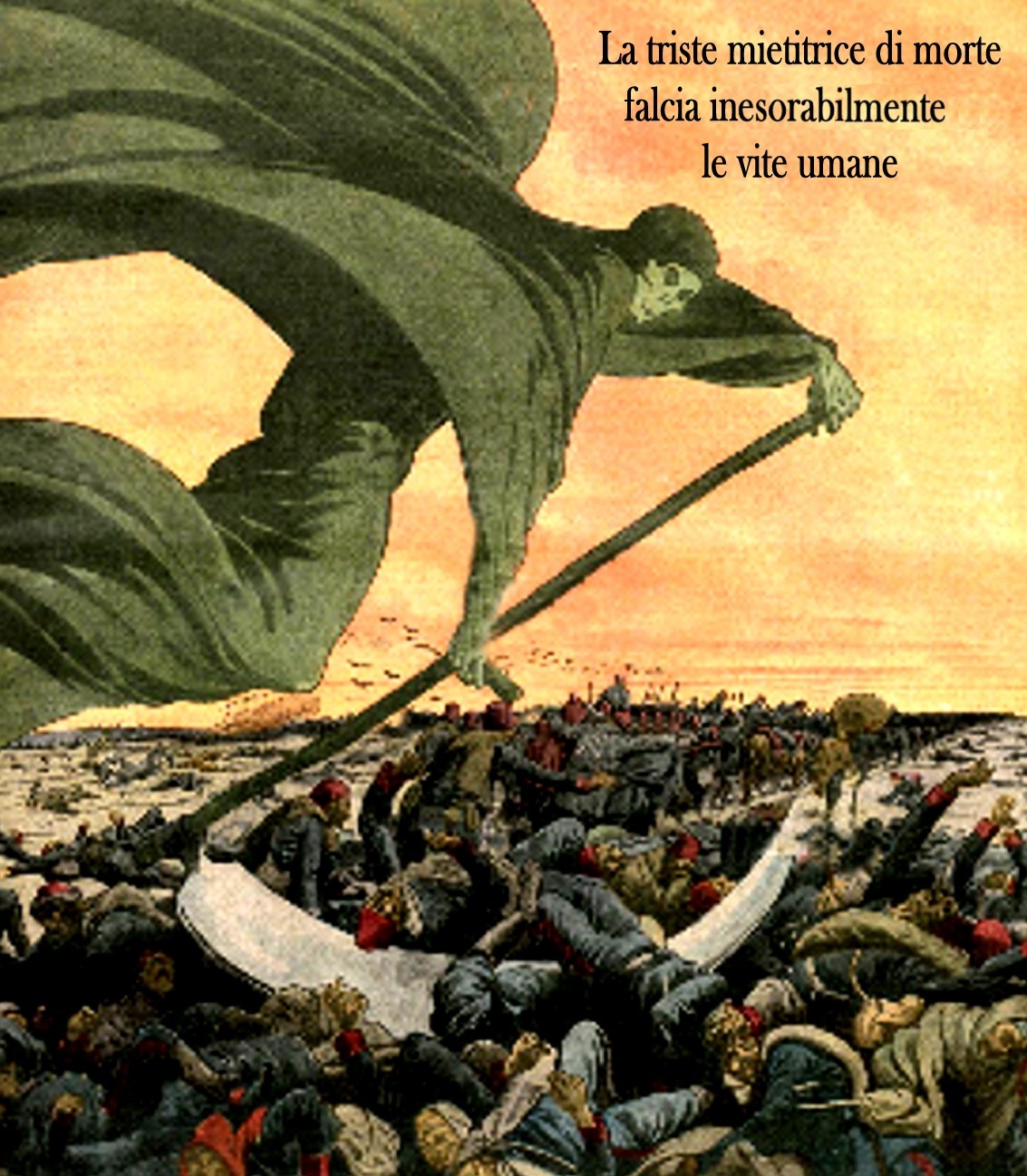
Il colera, infezione diarroica acuta
caratterizzata da una disidratazione a volte
fatale, è causato dall’assunzione di cibo o
acqua contaminati dal batterio Vibrio
cholerae
e, nonostante che sia facilmente curabile, esso
rimane una minaccia globale a causa della sua
elevata morbilità e mortalità in particolare
nelle popolazioni di alcune parti dell’Africa e
dell’Asia dove esiste un’assistenza sanitaria
inadeguata o prevalente assente. Negli ultimi
duecento anni a livello mondiale si sono
succedute ben sette pandemie di colera con 2,9
milioni di casi e 95.000 decessi ogni anno.
LA BIBLIOTECA COMUNALE
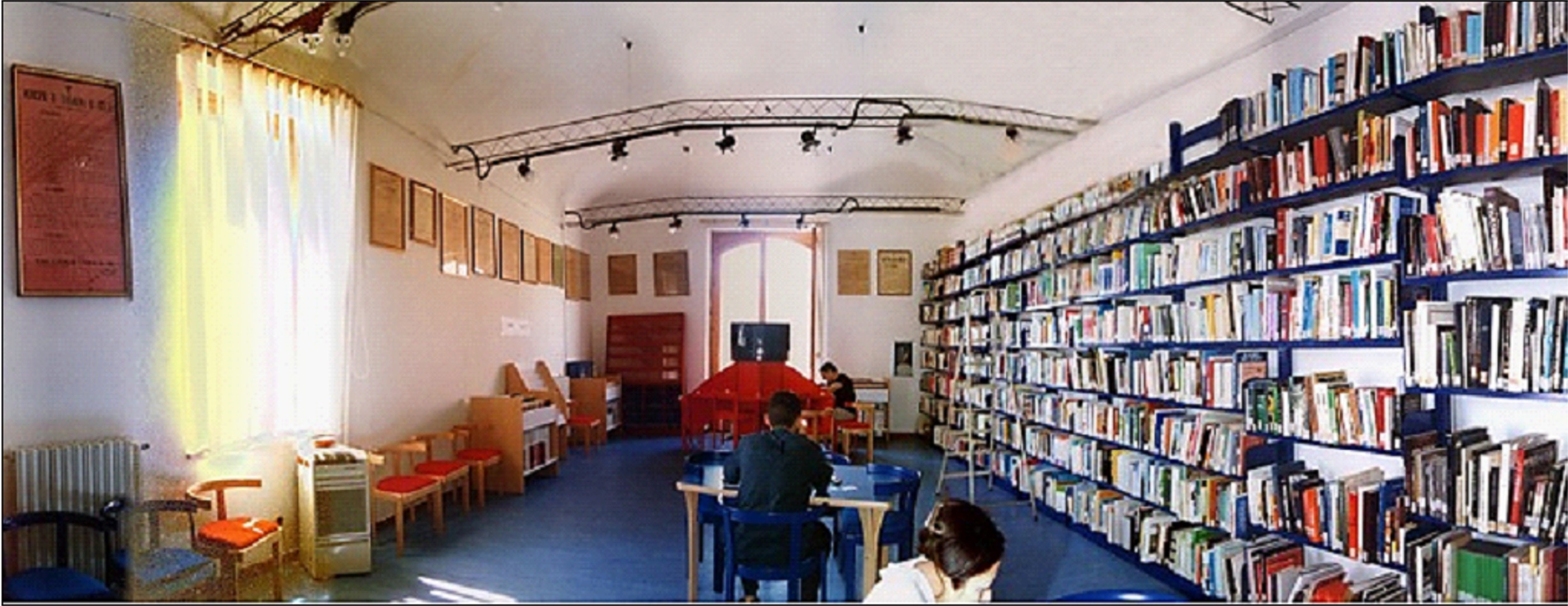
Sicuramente non
è compito facile gestire l’Assessorato alla
Cultura del nostro Comune vuoi perché le
Amministrazioni sono state quasi sempre
indolenti a questa tematica, relegandola spesso
agli ultimi posti dell’azione amministrativa,
vuoi perché si è perpetrata nei decenni una
scelta di persone che, da una parte, non sempre
sono state all’altezza del compito assegnato,
dall’altra, pur essendo competenti, non hanno
avuto un portafoglio adeguato a tale carica
assessoriale.
Tanti sono i casi
che si possono considerare a dimostrazione di
quanto si afferma e che si riferisce anche a
tutti i beni culturali presenti a Gela; anche se
in questo contesto entrano in gioco altre
istituzioni come il Parco Archeologico, la
Soprintendenza di Caltanissetta e gli
assessorati competenti della Regione Siciliana.
Ma l’esempio più
significativo è rappresentato dalla Biblioteca
Comunale il cui funzionamento è legato
all’azione amministrativa comunale che dovrebbe
garantire un pieno accesso alla “Cultura” in
tutte le sue sfaccettature con la convinzione
che essa appartenga a tutti, come l’aria e
l’acqua, e che in essa abbiamo tutti il diritto,
quindi anche l’obbligo, di impegnarsi. Come si
sa tale istituzione ha sede nell’edificio
all’angolo tra via Palazzi e Largo San Biagio,
fino a qualche lustro fa sede anche di due
assessorati comunali e una volta sede di un
lazzaretto e ancor prima di un convento dei
frati agostiniani.
Qui di seguito
riportiamo alcune notizie sulla storia della
nostra biblioteca che fu istituita
ben 150 anni fa, quando
un consigliere comunale della nostra città, tale
Santi Gioffrè, il 22 aprile
Le entrate del
nostro Comune nei primi decenni dall'istituzione
della biblioteca non permisero quasi mai un
adeguato stanziamento di fondi per il suo
funzionamento, dunque inizialmente si ebbero
pochi libri, molti problemi per il personale e
scarsità di suppellettili. Un primo notevole
contributo in libri si ebbe successivamente
quando furono esperite le pratiche dal Comune
tendenti a rilevare tutti quei volumi che si
trovavano nelle piccole biblioteche delle
corporazioni religiose terranovesi dopo
l’entrata in vigore della legge 7 luglio 1866,
n. 3036 e relativo trasferimento dei beni
ecclesiastici al demanio del Regno. In
particolare, più recentemente con
legge 20 maggio 1985 n. 222, fu istituito
il FEC (Fondo Edifici di Culto) che fu assegnato
al Ministero dell’Interno; a Gela tale Fondo è
proprietario delle chiese di San Francesco
d’Assisi, del Carmine, di Santa Maria delle
Grazie e di San Francesco di Paola. Come
dicevamo fu certamente un grosso contributo in
libri, però, soprattutto dal punto di vista
quantitativo, mentre da quello qualitativo fu
modesto, in quanto quei libri in modo
preponderante si riferivano ad argomenti di
Teologia.
Ai libri del Fondo
per il Culto si aggiunsero in vari periodi
quelli donati da diversi cittadini terranovesi
di cui ricordiamo gli eredi dell'Ing. Giuseppe
Di Bartolo e il Cav. Antonino Giurato.
Quest'ultimo oltre ai libri, donò pure al Comune
quattro importanti lettere autografe del grande
musicista Vincenzo Bellini, le quali furono
esposte in una bacheca nella sala consiliare; le
stesse lettere, però, nel 1896, su richiesta del
sindaco di Catania, furono a loro volta donate
al Museo Civico Belliniano di quella città dove
attualmente si trovano.
Diversi furono i
direttori onorari che nel tempo si avvicendarono
alla direzione della nostra biblioteca,
ricordiamo il sacerdote Don Giuseppe Solito e il
Preside Prof. Giovanni Mela, all'epoca titolare
della cattedra di Greco e Latino nel Regio Liceo
“Eschilo”; si deve proprio a quest'ultimo
direttore la creazione di un catalogo
sistematico dei libri.
Intorno al 1960
intanto, ad opera del Centro di Servizi
Culturali dell'ISES (Istituto per lo Sviluppo
dell'Edilizia Sociale), convenzionato con
Con fasi alterne
di chiusura ed apertura, la biblioteca comunale
ebbe il risultato di essere stata dimenticata
dagli stessi fruitori. Dopo la realizzazione del
nuovo Municipio, la biblioteca comunale dal
Convitto fu trasferita nei locali a pianoterra
dell’edificio dell’ex Pretura in via
Mediterraneo (Filippo Pane era il responsabile)
per poi passare nell’aula B, all’interno dello
stesso Municipio al primo piano, prospiciente
piazza San Francesco (responsabile la Sig.a
Vicino). Conobbe anche un periodo di profondo
degrado quando il suo locale venne addirittura
adibito anche a deposito di acqua minerale per
consiglieri e amministratori durante le riunioni
del civico consesso. In tutti quegli anni, e
forse questa è la cosa più deprecabile, non ci
fu mai un interessamento nè di associazioni che
si richiamano a scopi filantropici nè dello
stesso ambiente culturale gelese, ancora oggi,
purtroppo, restio e lontano dai problemi che
affliggono la nostra biblioteca.
Durante un lungo
periodo di inattività sparirono anche molti
libri; il compianto amico Gerlando Comandatore,
forse uno dei pochi che s'interessò veramente
alle sorti della nostra biblioteca, ci diceva
della sparizione di diversi pregevolissimi ed
inestimabili incunaboli e di tante altre
importanti opere antiche. In quali mani ignobili
andarono a finire non è dato sapere.
Ma fortunatamente,
est modus in rebus.
E infatti nel
1985, finalmente, la nostra biblioteca ricevette
un po’ di attenzione da parte
dell'Amministrazione comunale. Fu portato avanti
un progetto
di
ristrutturazione il cui risultato, tra l'altro,
fu quello del suo
trasferimento,
nella primavera
del 1986, nei
più ampi e funzionali locali di via Butera,
nella sede appena ristrutturata dell'ex Convento
dei PP.
Agostiniani, contigua al cimitero monumentale,
sede
inaugurata nel
dicembre dello
stesso anno in
occasione delle
onoranze in
memoria del compianto concittadino Prof.
Emanuele Morselli (1899-1975), eminente studioso
e illustre concittadino. Per ricordare il Prof.
Morselli oltre l’intitolazione di una locale
scuola superiore, fu realizzato dai suoi parenti
un busto bronzeo con piedistallo che fu ubicato
nel giardinetto contiguo alla biblioteca, busto,
però, che nei primi mesi del 2024, è stato
trafugato.
Perché quindi si è
scelto di scrivere della biblioteca comunale? Il
motivo è semplice! Perché la biblioteca, prima
che fosse confortata dall’attenzione delle
ultime amministrazioni comunali, nell’ultimo
ventennio è stata dimenticata e abbandonata;
infatti, da anni non venivano acquistati libri,
dei 6 computer in dotazione ne funzionavano solo
due e non avevano nemmeno la possibilità di
collegamento a internet a parte l’obsolescenza
degli stessi (si figuri che come sistema
operativo utilizzavano ancora il
Window XP professional,
nato nel 2001, con microprocessore
pentium,
commercializzato a partire dal 1993). Esisteva
pure un servizio di emeroteca, un servizio di
quotidiani e settimanali fruito da molti
cittadini, che è stato soppresso, si immagini
quale “enorme spesa” il Comune avrebbe dovuto
sostenere. Da aggiungere pure l’esistenza di
un’idea-progetto su tutto l’edificio che ospita
la biblioteca, approntato gratuitamente qualche
anno fa dalla Dott.ssa Giorgia Turco e dallo
scrivente sulla rimodulazione dei vari servizi
di consultazione, che non si sa che fine abbia
fatto.
Con queste
considerazioni si è ritenuto opportuno sollevare
il problema perché veramente piange il cuore nel
constatare il lassismo sul bene culturale che
dura già da quasi mezzo secolo e, in
particolare, nel vedere abbandonata la nostra
Biblioteca, importante e nobile istituzione
cittadina che dovrebbe essere rimodulata cosi da
stare al passo con i tempi moderni. A parte le
sollecitazioni continue dei funzionari della
Biblioteca, tutto quanto scritto sopra ha
rappresentato il contenuto di diverse lettere
aperte inviate periodicamente dallo scrivente al
Comune di Gela.
La Biblioteca
comunale nel 2021 è stata chiusa alla pubblica
fruizione per una sua necessaria e indifferibile
ristrutturazione. Dopo una prima inaugurazione
della consegna dei locali, fatta dalla
precedente amministrazione nel 2023 e una
seconda dall’attuale il 15 novembre del 2024, la
biblioteca comunale, anche con diverse
inefficienze, lunedì 18 novembre 2024 ha
riaperto i battenti.
In chiusura si
desidera far conoscere quanto di importante si
trova tra i 35.000 libri nella nostra biblioteca
a parte i costosi volumi della Treccani e di
altre opere che nel corso dei passati decenni
l’hanno impreziosita. Ci riferiamo al Fondo
Antico dei libri che è costituito da circa 2.500
volumi, a partire dall’anno 1581, che trattano
di diverse tematiche, dalla Filosofia alla
Religione, dall’Architettura (con diverse opere
di Palladio) alla Medicina, dalla Storia antica
e moderna alla Geografia, dalla Letteratura alla
Giurisprudenza, dall’Agricoltura all’Economia
oltre a prediche, sermoni, retorica,
quaresimali, opera omnia, Bibbia e Antico e
Nuovo Testamento; ed ancora commentari,
panegirici, trattati, orazioni, trattati di
teologia morale, dizionari, saggi, novelle,
narrativa, ecc.
Oltre ai libri
classici della nostra letteratura (come il
Decamerone
di G. Boccaccio del 1804,
Le Rime
di F. Petrarca del 1805, dell’Orlando
Furioso di L.
Ariosto del 1812), sono anche presenti opere che
hanno riferimenti alla nostra città in antico
come:
Sicilia Sacra
di R. Pirri del 1641,
Biblioteca Sicula
di Antonio Mongitore del 1707,
La Sicilia in prospettiva
di G.A. Massa del 1709,
Della Storia di Sicilia
di Tommaso Fazzello del 1817, Delle Memorie
istoriche dell'antica città di Gela nella
Sicilia del 1753 opera del carmelitano Carlo
Filiberto Pizolanti,
ecc.